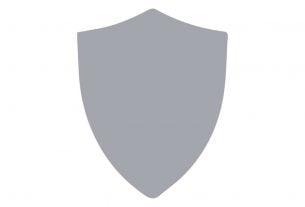Le telecamere stringono l’inquadratura sugli spalti: un bambino tiene in alto una sciarpa azzurra, con una N blu inscritta in un cerchio dello stesso colore. Qualche minuto dopo, una bambina sventola una bandiera azzurra, accennando un sorriso timido. Sono immagini classiche, che riempiono i tempi morti e i prepartita della Serie A da anni. Qui però qualcosa stona: dietro quei primi piani non si intravedono macchie dello stesso colore, ma un giallo diffuso, come se stessimo fotografando il fusto di una palma nel mezzo del deserto. Effettivamente a un deserto assomiglia il King Saud University Stadium, casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, nella semifinale di Supercoppa italiana 2023 tra Napoli e Fiorentina. A un’occhiata superficiale l’affluenza non pare molto diversa da una partita del campionato italiano, magari fissata alle 12:30 di un’uggiosa domenica autunnale, ma appena l’inquadratura allarga il raggio d’azione sulle curve, ci si rende conto che le sezioni di campo dietro le porte sono quasi completamente vuote, così come i seggiolini in cima alle tribune.
Per novanta minuti è sembrato di tornare alle partite giocate in Serie A dopo la prima ondata di Covid-19, con l’affluenza negli stadi limitata a mille spettatori nel simbolico tentativo di riportare una parvenza di normalità in un’atmosfera surreale. L’audio ha contribuito a rendere la sensazione di déjà-vu più forte, il silenzio degli spalti coperto dalla telecronaca e dalle esclamazioni sporadiche di chi in campo o in panchina. Se la partita fosse stata commentata da Fabio Caressa, quasi ci saremmo aspettati un improvviso e fuori contesto «immergiamoci!».
Di fronte al palese disinteresse verso il calcio italiano che una parte del mondo arabo ha mostrato, domandarsi perché la Supercoppa sia stata calata in quel contesto sterile non riguarda soltanto noi – cosa il nostro calcio perde e cosa guadagna quando si presta a questo tipo di operazioni – ma anche loro: cosa spinge una lega sportiva, un governo, una famiglia reale – in questo caso quasi perfettamente sovrapponibili nella stessa figura – a versare nelle casse della Lega Calcio 23 milioni di euro? Si può ancora parlare di sportwashing, se l’operazione è così palese da risultare grottesca, più che affascinante?
Ciò che lo spettatore si aspetta, in un buon gioco di prestigio, è di essere ingannato: accetta implicitamente di star assistendo a un trucco, e lo va cercando nelle pieghe dei vestiti dell’illusionista, o nel movimento innaturale di una sua mano, o in qualsiasi altro gesto sospetto che l’occhio vuole avidamente trovare, senza alla fine riuscirci. È il dubbio a tenere viva la sua attenzione, insieme alle luci soffuse e alla tensione che si crea nell’attesa, condivisa con tutti gli altri presenti in sala. Cosa succederebbe se il prestigiatore riaccendesse le luci, scendesse dal palco e si mettesse a spiegare per filo e per segno come ha fatto a far sparire la colomba dentro la sua gabbietta? O se, peggio ancora, lo mostrasse semplicemente, diradando l’inganno in un secondo? Qualcuno sarebbe ancora disposto a pagare il prezzo del biglietto, sapendo che il patto è stato violato?
Quanti italiani, dopo questa Supercoppa, mostreranno interesse verso la cultura calcistica araba, e quanti arabi saranno più interessati al movimento italiano, all’infuori di chi era già abituato a sostenerlo? Quanti italiani si ricrederanno sul sospetto che tutto questo venga fatto per ragioni puramente economiche, e quanti invece confermeranno quel sospetto? Quanti, allargando il campo alle notizie che riportano fughe di massa da parte di giocatori che si erano stanziati lì solo sei mesi fa, sceglieranno di visitare l’Arabia Saudita o di andarvi a lavorare, a dispetto di qualunque cifra abbia percepito Leo Messi per diventarne sponsor ufficiale?
La sensazione è che l’obiettivo di coloro che hanno messo in moto l’enorme macchina sportiva del Golfo, ormai accesa da anni, non sia più quello di lavare l’immagine dei propri governi – forse questo non è mai stato nei loro piani – ma di far prendere coscienza al mondo dell’esistenza stessa di quei governi, della loro capacità di richiedere e ottenere quello che desiderano, e che questo possono farlo nel minor tempo possibile; di poter assumere un ruolo internazionale di rilievo a scapito della loro immagine, dell’aria di pariah che si portavano dietro fino a pochi anni fa; di poter sottolineare la superiorità del denaro rispetto ai valori occidentali, o orientali, o talvolta semplicemente etici di cui il mondo attorno a loro si riempie la bocca con tanta convinzione – portando a Dubai la COP 28 per il 2023, ad esempio – e contemporaneamente la connivenza dei governi occidentali verso questo tipo di comportamento. Accordo dopo accordo, l’asticella su cosa sia lecito accettare si sposta un po’ più in alto, perché in realtà è il peso dell’opinione pubblica a spostarsi sempre più in basso, fino a renderlo irrilevante negli schemi delle scelte istituzionali. Quello che sembrava sportwashing diventa un modo per stabilire rapporti di forza internazionali, basati su una struttura che sottrae un grado di complessità alla politica o che, se vogliamo, rende meno necessario adottare compromessi e soluzioni di facciata.
Dicevamo che questo non riguarda soltanto loro, ma anche e soprattutto noi. Perché gli accordi vengono trovati quando c’è spazio per negoziare, e la Lega Serie A si è fiondata in quello spazio come un uomo disidratato di fronte al primo specchio d’acqua che gli capiti di vedere da giorni. Una Lega che fatica a trovare finanziamenti per mantenere il brand del campionato italiano appetibile nel lungo periodo; un campionato che da poco ha anche perso uno dei pochi vantaggi competitivi che ancora gli permetteva di attirare atleti e allenatori di livello dall’estero, e cioè il Decreto Crescita. Una Lega che, prima ancora dei finanziamenti, manca di idee valide che permettano al movimento calcistico di rinnovarsi, come testimonia lo scimmiottamento del format della Supercoppa, mutuato da quello spagnolo – che ha attirato diverse critiche anche in patria.
È chiaro che il tornaconto economico nello spostare la baracca di una competizione considerata marginale dall’opinione pubblica possa sembrare un modo semplice per racimolare una discreta cifra, anche dalle stesse squadre coinvolte direttamente nell’operazione – che in totale raccoglieranno 16,2 milioni di euro dei 23 complessivi –, e che prima di oggi vedevano la Supercoppa solo come una perdita di tempo, un’appendice inutile a un calendario già intasato. Con l’aggiunta della semifinale e l’allargamento a quattro squadre hanno sì aumentato gli impegni a discapito della condizione fisica dei giocatori, ma hanno trovato il modo di spremere un altro po’ d’acqua da uno straccio quasi asciutto. L’iniziativa è stata possibile anche grazie a una certa disaffezione del pubblico verso le coppe nazionali, che da anni vedono un’affluenza minima.
Così, invece di cercare di capire cosa rendesse scadenti dei prodotti come la Supercoppa italiana, di chiedersi perché durante le partite di Coppa Italia gli stadi di grande capienza venissero disertati e perché gli stadi delle squadre di provincia rimanessero chiusi, si è scelto di girarsi dall’altra parte, copiando per filo e per segno le soluzioni attuate da altre leghe, trasferendo in un contesto alieno un relitto del passato e non funzionante, cercando di abbellirlo con soluzioni spicciole. Se gli stadi in Italia erano mezzi vuoti, meglio svuotarli del tutto così da non dover pagare i costi per l’apertura degli impianti, evitare le noie di ordine pubblico, assicurandosi in cambio una cospicua mancia da parte di qualcuno che ha interesse a trasformare l’evento in un’installazione itinerante, una specie di ‘Toto Forever‘. Come Maurizio Sarri ha fatto notare in un’intervista recente: «Prendi i soldi e scappa».
I tentativi di giustificare il format da parte dei vertici istituzionali italiani – format che resterà in vigore fino al 2027, con saltuari cambi di location – per nascondere il peso dell’aspetto economico nella scelta della Lega ha soltanto generato altre polemiche: il Ministro per lo sport e per le politiche giovanili Andrea Abodi ha affermato che «non è soltanto la ricerca di un montepremi, ma il contributo anche all’obiettivo, che va perseguito, della democrazia e dell’affermazione del rispetto in tutte le sue forme». L’obiettivo, insomma, deve essere anzitutto quello di «illuminare quei luoghi, responsabilizzarli e contribuire all’alfabetizzazione civile». Tralasciando i discorsi sul presunto diritto che una cultura avrebbe di insinuarsi sottopelle a un’altra per “esportare la democrazia” – se questo sia giusto, quanto sia giusto, fino a che limite ci si possa spingere nel mettere in atto questi tipi di azione –, la goffaggine delle dichiarazioni nasconde un altro elemento interessante: la paura di non aver scelto, ma di essere stati scelti. In qualche modo, le parole del ministro cercano di rassicurarci, e rassicurarlo, sul fatto che non è stata accettata un’offerta che non si poteva rifiutare, ma che si è agito da protagonisti, in nome di ideali nobili e una superiorità culturale e morale, prima di tutto: la Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita non in seguito a un invito, ma come diretta conseguenza di una volontà specifica da parte delle nostre istituzioni.
A vantaggi immediati, però, seguono implicazioni difficili da valutare nel lungo periodo: si è presa una scelta apparentemente consapevole delocalizzando la competizione, puntando sulla disaffezione del pubblico e su un guadagno istantaneo, ma lo sguardo della Lega si è fermato qui. Si è portato il calcio nell’iperreale scommettendo sulla presenza sempiterna degli spettatori dietro lo schermo, confidenti della loro bulimia quotidiana, la loro capacità di riempirsi con qualsiasi forma di intrattenimento sportiva gli si getti nel piatto. Si gioca con l’idea che il contesto non sia importante, l’impiattamento un fattore marginale nella preparazione di un evento; ma il calcio, di per sé, può essere molto noioso: è la caratteristica degli sport a basso punteggio, pieni di momenti di nulla tra un’azione e l’altra. La sua forza attrattiva sta nella capacità di potervi costruire un numero pressoché infinito di storie attorno, storie fatte di spalti pieni, cori ed esultanze; storie di collettività e di condivisione di emozioni, di tensione e di delusioni. Lavorare per sottrazione, eliminando via via il contorno fino a lasciare scoperta la materia prima, ci avvicina pericolosamente a privarci di quelle stesse storie che alimentano il nostro interesse. Di qui a qualche anno, chi ha deciso di portare il calcio italiano fuori dall’Italia potrebbe rendersi conto che non resta più niente da esportare, perché dietro gli schermi non è rimasto più nessuno.
Leggi anche: Il calcio, l’aggregazione e la salute mentale